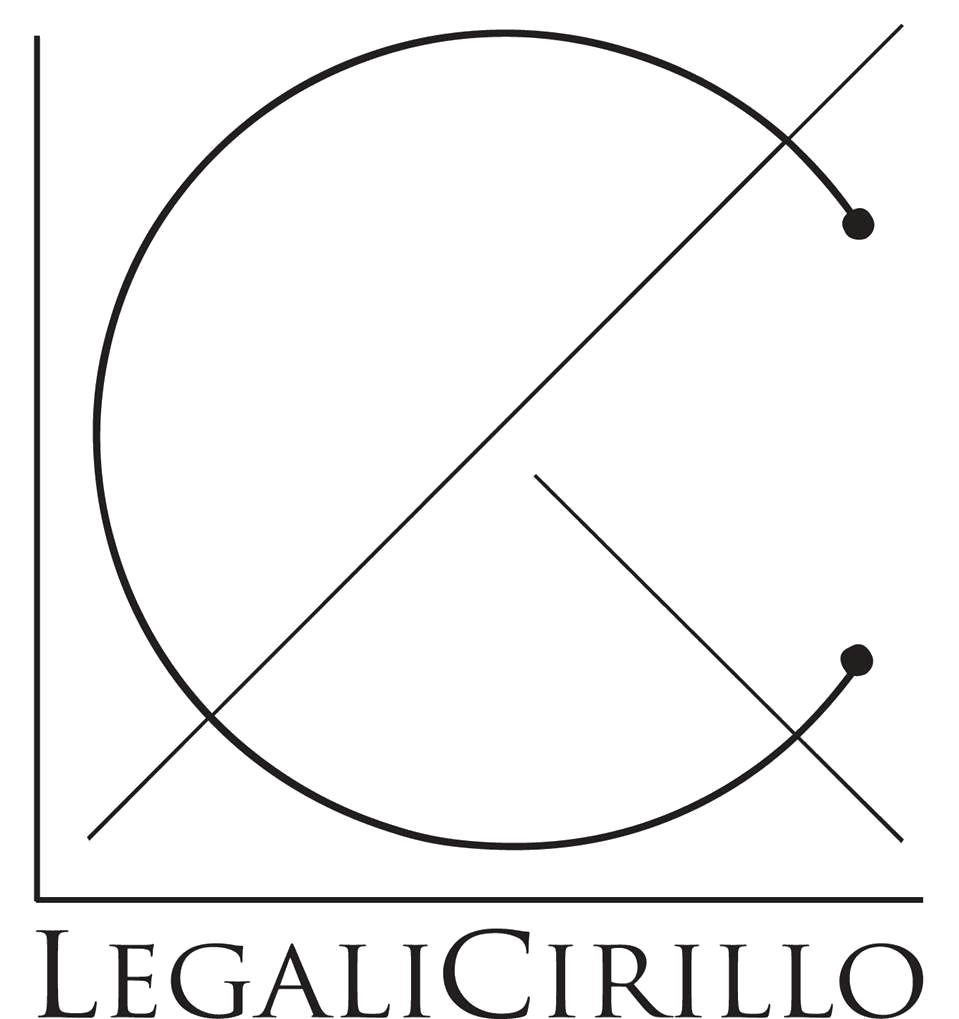Per i giudici della Corte d’Appello di Napoli, nella sentenza n. 2372/2013, “[…] l’oggetto della cessione deve riguardare beni materiali ed immateriali che rendano il ramo di azienda, così come individuato nel contratto, capace di funzionare in modo autonomo, per cui detta autonomia deve essere esclusa allorquando i beni ceduti non siano idonei ad assicurare il servizio, che richiede per il suo espletamento la messa a disposizione di altri beni dei quali, invece, il cedente si riservi la proprietà. Né d’altro canto l’autonomia può essere fatta discendere dai soli interventi effettuati dal cessionario dopo l’acquisizione, giacché […] le modificazioni introdotte dall’acquirente devono comunque riguardare una entità già in grado al momento della cessione di funzionare in modo autonomo. Né, ancora, vale obiettare che può ravvisarsi una cessione di ramo d’azienda anche in presenza del trasferimento di sola manodopera e, quindi, di soli lavoratori che per aver acquisito un complesso di nozioni e di esperienze, siano capaci di svolgere le loro funzioni presso il nuovo datore di lavoro“.
Il Collegio, in particolare, ha osservato che, in tema di cessione di ramo d’azienda, la disciplina dettata dall’art. 2112 c.c., nella sua stesura applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, deve essere applicata anche nei casi di “trasferimento di parte dell’azienda intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economicamente organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento“.
Tale formulazione, viene rilevato, “non si presta né ad interpretazioni totalmente restrittive, che finiscano per privare di qualsiasi significato l’intervento legislativo, né a esegesi che in senso opposto demandino alla esclusiva volontà delle parti ogni scelta, ritenendo quindi che il ramo di azienda debba essere individuato come tale solo perché così qualificato dai contraenti“.
Il fatto, poi, che il legislatore abbia previsto definito il ramo d’azienda come “articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata“, fa ritenere fuori di dubbio “che cedente e cessionario possano definire i contenuti e l’insieme dei mezzi oggetto del negozio traslativo, delineando i confini di un’entità che può anche non essere preesistente al trasferimento, purché, all’esito dell’individuazione si configuri un’articolazione autonoma, capace cioè di perseguire lo scopo economico prefissato con i propri autonomi mezzi, che possono essere integrati da interventi effettuati dal cessionario, a patto che l’autonomia non discenda esclusivamente da questi ultimi. L’autonomia funzionale dell’attività da cedere costituisce, quindi, il filtro selettivo che consente di distinguere la legittima cessione del ramo d’azienda, riconducibile allo schema tipico delineato dall’art. 2112 c.c., da operazioni di scomposizione e di smembramento indiscriminato dell’azienda, che finiscano per risolversi in una espulsione non controllata di forza lavoro“.
Quindi, sostengono i giudici, non è condivisibile la tesi di chi ritiene che il d.lgs. n. 276/2003, modificativo della norma in parola, abbia legittimato un “criterio soggettivo di identificazione del ramo di azienda“, consentendo alle parti di disporre degli effetti giuridici dell’atto a prescindere da vincoli oggettivi in quanto la norma, pur “eliminando il requisito della preesistenza ma ribaltando la necessità dell’autonomia funzionale, ha solo consentito al titolare dell’impresa di intervenire sulla organizzazione aziendale e di modificarla, anche nella immediatezza del negozio di cessione, in modo da costituire un ramo di azienda dotato di sua autonomia organizzativa, che deve però effettivamente sussistere al momento del trasferimento ed essere apprezzabile da un punto di vista oggettivo, essendo escluso che dalla stessa si possa prescindere o che la stessa possa esistere solo nella volontà delle parti“.
La formulazione dell’art. 2112 c.c., dunque, non ha legittimato tutte le operazioni di “esternalizzazione” di servizi, “né tanto meno una pura e semplice espulsione di quote di personale, attuata evitando all’imprenditore di affrontare i costi ed i rischi di un licenziamento collettivo e privando i lavoratori delle relative tutele“. Troviamo autorevole conferma di tale interpretazione nella giurisprudenza di legittimità (sent. 8 giugno 2009, n. 13171) laddove “in materia di trasferimento di parte (c.d. ramo) di azienda, tanto la normativa comunitaria (direttiva CE nn. 98/50 e 2001/23) quanto la legislazione nazionale (art. 2112, comma quinto, cod. civ., sostituito dall’art. 32 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276) perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell’attitudine a proseguire con continuità l’attività produttiva. La citata direttiva del 1998 richiede, pertanto, che il ramo d’azienda oggetto del trasferimento costituisca un’entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un’attività economica, essenziale o accessoria e, analogamente, l’art. 2112, quinto comma, cod. civ. si riferisce alla “parte d’azienda, intesa di un’entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all’esecuzione di una sola opera (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00), ovvero di un’organizzazione quale legame funzionale che renda le attività dei lavoratori interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati“.
Pertanto, discende dalle considerazioni che precedono che, anche nel mutato contesto normativo, il ramo deve presentarsi “come una sorta di piccola azienda in grado di funzionare in modo autonomo e che non deve rappresentare, al contrario, il prodotto dello smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate tra loro” (Cass. 4 dicembre 2002, n. 17207).
(Fabio Capone)